Qual è il gioco di Sophie Calle?
Appunti sulla figura dell’autore nell’opera di Sophie Calle.

La problematizzazione della figura dell’autore è uno dei sintomi più evidenti della modernità (per limitarsi ai primi nomi che mi vengono in mente, basta pensare all’opera letteraria di Pirandello e di Pessoa, alla “produzione” di Duchamp, alle teorie di Barthes, tutte così profondamente “segnate” da questo nodo d’ordine concettuale)1.
Nel panorama delle arti visive Sophie Calle (Parigi 1953) è uno dei “casi” più interessanti di una pratica d’incontro tra il dominio della letteratura e quello della fotografia, e sembra indicare, attraverso il suo lavoro, con particolare insistenza proprio la problematicità della figura dell’autore. Le sue azioni artistiche sono la risposta alla necessità di ristabilire una ritualizzazione dell’ordinario, in qualche modo avvalendosi anche del modello dell’autobiografia.
Ma vediamo di procedere con ordine e di stabilire, prima di occuparci del tema centrale di questo intervento, in che misura, in che modo e con che funzioni, la letteratura sembra rientrare nell’officina della creatività di Calle. Infatti nel suo lavoro accade da questo punto di vista qualcosa di molto singolare che, nonostante l’equilibrio mantenuto fra il dominio visivo/fotografico e quello “intellettuale” del testo - equilibrio che affida , come nell’opera della maggior parte dei narrative artists2, un ruolo in egual misura centrale ai due linguaggi in questione - fa pendere la bilancia decisamente dalla parte della letteratura. Se gli anelli della “catena simbolica” del discorso di Calle alternano in una scansione regolare immagine e testo, il funzionamento della sua officina creativa sembra invece basarsi prevalentemente su meccanismi letterari e organizzarsi sempre di più con il passare del tempo intorno a idee e materiali “rubati” dall’ambito della scrittura, del racconto e del romanzo, della fiction. La labilità dei confini tra realtà e finzione è in questo lavoro clamorosamente accentuata, e i due regimi si mescolano di continuo inscindibilmente.
Ma vediamo adesso di entrare più nello specifico dell’opera per riscontrare nella concretezza di alcuni lavori l’entità e la portata di questa relazione che nel corso del tempo è divenuta progressivamente sempre più significativa.
Nella prima stagione del suo lavoro, dalla fine degli anni Settanta, Sophie Calle si dedicava prevalentemente a “prelevare” con occhio fotografico attento e rapace una serie di eventi quotidiani, restituendo, attraverso la registrazione fotografica e la descrizione verbale, una sorta di campionatura di situazioni. Il linguaggio che accompagnava le immagini non dimostrava alcuna inclinazione alla poesia, anzi i testi da lei composti somigliavano più a sceneggiature, comunicati o resoconti scientifici, descrittivi e strumentali, collocabili nell’ambito di una scienza umanistica che combina interessi antropologici e sociologici; il tono era assai lontano dallo stile intimista del diario come dai tentativi di ricostruzione di un’esperienza personale che compongono generalmente un reportage. Insomma, il tono del discorso non è né psicologico né confessionale, anzi i testi ci informano delle “regole del gioco” rispetto alle quali sono venute a formarsi le immagini, illuminano la scelta o l’inciampo dell’autore in base a cui le fotografie sono “nate”. E’ evidente che questa “forma doppia” composta di fotografia “sensibile” combinata al testo “concettuale” permette a Sophie di stare contemporaneamente dentro e fuori da entrambi i linguaggi, mentre crea una rete per lo spettatore che, messo al corrente del “motore” che ha spinto ad aggregare queste e non altre immagini con questi e non altri testi, è chiamato come testimone di un processo fatto di piccoli misteriosi fatti ordinari e quotidiani.
Nessuno degli eventi “prelevati” è sensazionale o spettacolare: la vita scorre nella sua ordinarietà. Molti dei fatti “congelati” dalla Calle sono a carattere autobiografico3, e la sua operazione dimostra di avere spesso chiare finalità esorcistiche. Se da un certo punto di vista si può affermare che la pratica psicoanalitica ha come finalità una sorta di “ricomposizione” del racconto autobiografico del paziente, il lavoro di Sophie Calle dimostra tangenze anche con la psicoanalisi. Il nesso, appariscente in Appointement with Sigmund Freud (1998)4, è intimamente sotteso alla maggior parte dei suoi lavori.
Douleur exquise (1984-2003) è un’opera particolarmente emblematica poiché esibisce con cristallina trasparenza il valore auto-terapeutico della creatività:
Je suis partie au Japon le 25 octobre 1984 sans savoir que cette date marquait le début d’un compte à rebours de quatre-vingt-douze jours qui allait aboutir à une rupture, banale, mais que j’ai vécue alors comme le moment le plus douloureux de ma vie. J’en ai tenu ce voyage pour responsable. De retour en France, le 28 janvier 1985, j’ai choisi, par conjuration, de raconter ma souffrance plutôt que mon périple. En contrepartie, j’ai demandé à mes interlocuteurs, amis ou rencontres de fortune: “Quand avez-vous le plus souffert?” Cet échange cesserait quand j’aurais épuisé ma propre histoire à force de la raconter, ou bien relativisé ma peine face à celle des autres.5
Questo lavoro è organizzato quindi sulla ripetizione della rivisitazione di un determinato evento particolarmente traumatico per l’autore, rivisitazione che avviene attraverso l’iterata presentazione della stessa fotografia della stanza d’albergo in cui il dolore si è insinuato “via cavo”, fotografia in cui infatti troneggia un telefono rosso sangue appoggiato sul letto, e attraverso un testo d’accompagnamento, questo sì sempre diverso, sempre meno partecipato e dettagliato, sempre più distaccato e breve. L’ossessivo ritorno della stessa immagine è alternato all’esposizione visiva e verbale di un altro caso “clinico” che ha come effetto il portare distanza allo sguardo che prende nuovamente in esame il proprio caso personale. Il titolo, Douleur Exquise, tratto dal lessico medico ove sta a designare un dolore acuto che si localizza in una specifica parte del corpo, richiama peraltro uno dei giochi preferiti nella cerchia dei surrealisti, il Cadavre exquis, nato dalla performance sullo stesso foglio di più mani che ignoravano a vicenda l’operato altrui, e questo rimando mette nuovamente al centro dell’attenzione la letteratura come modello, poiché, com’è noto questo gioco nacque originariamente in ambito letterario prima di essere preso a prestito dagli artisti visivi.
Presenta connotazioni fortemente autobiografiche e finalità altamente terapeutiche anche e soprattutto il film Double Blind.No Sex last Night (1992), che Sophie ha girato a quattro mani in California con Greg Shepard. Il film, fatto di spezzoni girati da l’uno e dall’altra mentre l’occhio di ciascuno, protetto dietro il diaframma della videocamera, spiava l’altro (in tutto il film non c’è neppure una scena a due), non “registra” solo le enormi difficoltà comunicative in cui la coppia si era incagliata senza vie d’uscita, ma diventa indicativo della difficoltà del desiderio a rapportarsi alla realtà, dello sguardo a farsi partecipazione.
L’attitudine performativa dell’opera di Sophie Calle, evidente in Le rituel d’anniversaire6, rimanda al lavoro di Marina Abramovic, che nella sua vita ha sentito più volte la necessità di ritualizzarne gli eventi “di passaggio” attraverso azioni artistiche (in particolare penso alla sua ultima performance con Ulay, quando scelsero di incontrarsi sulla muraglia cinese arrivando da due direzioni opposte per dirsi definitivamente addio, per separarsi rompendo un sodalizio sentimentale e artistico che durava da più di dieci anni). Tra Abramovic e Calle si da un’altra sbalorditiva affinità d’ordine puramente biografico, ma stabilire un confine tra vita e opera in queste artiste è qualcosa di artefatto e privo di senso, e sta nella bizzarra coincidenza che ciascuna di loro ha conosciuto e amato “un proprio gemello astrale”, un uomo nato nello stesso giorno e alla stessa ora.
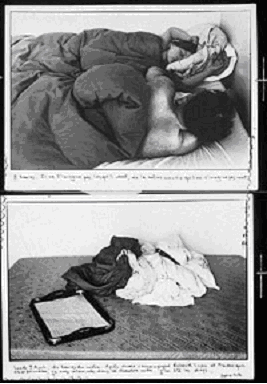
Se la componente voyeristica che è il più potente motore, Benjamin direbbe attrattore, dell’opera di Sophie si esplica in modo particolarmente paradigmatico in Les Dormeurs (1979), composto da una serie di centosettantasei fotografie in bianco e nero scattate tra il 1° e il 9 aprile del 1979 a ventisei persone, anche e soprattutto sconosciute, invitate a passare la notte nel suo letto a patto di lasciarsi fotografare mentre dormivano -ospiti e al tempo stesso ostaggi-, la sua vocazione indagatrice si esplicita con forza in Suite venitienne (1979-80) lavoro nato dall’idea di seguire persone sconosciute incontrate casualmente per strada per fotografarne le “mosse”. Baudrillard scrive un testo di accompagnamento per la pubblicazione di quest’opera significativamente intitolato Please, follow me: il filosofo ne individua il nucleo problematico nella relazione tra sé e l’altro, riportandolo al concetto di seduzione a cui egli stava lavorando da tempo:
Ci si seduce attraverso l’essere assenti, attraverso l’essere niente più di uno specchio per l’altro che non lo sa.7
E tutta l’opera di Sophie sembra davvero farsi leggibile in modo trasparente attraverso la “lente” dell’impossibilità di carpire davvero il segreto dell’altro, e come dell’altro, anche di sé stessi. Je est un autre: i versi di Rimbaud rieccheggiano in tutto il suo lavoro e in particolare in La Filature (1981), dove, sottolineando l’inquietante reversibilità dei ruoli, Sophie dimostra, già ben prima di esplicitarlo macroscopicamente nella recente “collaborazione” con lo scrittore Paul Auster, di non amare i giochi “a senso unico” e di prediligere quindi il “doppio gioco”.
Il Centre Pompidou mi invitò a una collettiva intitolata Autoportraits, pensai che l’unico modo per autoritrami, dopo aver seguito tanta gente, era riversare i ruoli, sebbene io fossi consapevole che un uomo mi stava seguendo. 8

Diptyque composé de textes et de photographies n/b, 162 x 110 cm (chacun)
In questo caso si fa a sua volta pedinare e fotografare da detective professionisti, come per pareggiare i conti, e tentare di vedersi attraverso occhi altrui, come se la distanza potesse garantire un “vero vedersi”. Com’è ovvio, le fotografie che compongono la narrazione non sono autografe, non sono state scattate dall’artista, ma sono oggetti di un’appropriazione di matrice duchampiana (questa operazione si pone agli antipodi rispetto alla concezione artigianale dell’arte, ma questo punto era già chiaro nei discorsi precedenti).
È adesso evidente che lo sviluppo creativo di Calle ha bisogno dell’implicazione “altrui”, che la sua opera si configura quindi come una sofisticata e complessa forma di dialogo, o meglio, come una partita, un insieme di mosse sulla scacchiera. Almeno un partner è indispensabile a ogni gioco di società e presto vedremo come si articola complicandosi in modo fertile il gioco quando “dall’altra parte del tavolo” si trova uno scrittore come Paul Auster.
Ma prima di affrontare quel recente e significativo capitolo dell’opera e della vita (come scindere i due piani?) di Sophie Calle, è opportuno concentrare l’attenzione sul legame che il suo “fare arte” ha con la letteratura. Uno dei primi aspetti che salta agli occhi nel prendere in esame la produzione tutta di Calle è che senza sforzo se ne identifica la sua forma più compiuta, piuttosto che nell’esposizione sulle pareti di un museo o di una galleria d’arte, nella pubblicazione9, nel libro e nei cofanetti che raccolgono più volumi di lavori tematicamente affini, in cui il fitto gioco di rimandi tra un lavoro e l’altro si svela più agilmente.
La sua fiducia nel linguaggio verbale, orale e scritto, è costantemente manifestata in ogni lavoro, ma si rende evidente soprattutto in opere come Les Aveugles (1986) e Fantômes (1989-1991). Nel primo caso Sophie ha costruito il lavoro a partire dalla cecità, dalla negazione della vista ordinaria, per riapprodare da questa sponda lontana nuovamente alle immagini. L’opera nasce per la volontà dell’artista d’incontrare un certo numero di persone non vedenti dalla nascita, chiedendo loro di poter scattare a ciascuno un ritratto fotografico e di raccogliere una loro testimonianza, più precisamente di sapere e trascrivere quale fosse l’idea di bellezza che si era venuta formando in ciascuno di loro; una volta ottenute le indicazioni richieste Sophie ha cercato di selezionare fra le visioni “disponibili nel mondo reale” quelle che parevano avvicinarsi di più alle immagini mentali dei suoi “ispiratori” ciechi, le ha quindi fotografate ed esposte come terzo elemento di un trittico formato nelle sue altre parti dal ritratto fotografico del non vedente e dalla trascrizione del suo discorso sulla bellezza. Fantômes e altri lavori affini come Disparitions (1990), invece si avvalgono proprio esclusivamente della parola per ricordare qualcosa che non è più visibile. In questo caso il “set” è un museo e lo spunto proviene dall’assenza di alcune opere che lasciano vuoto lo spazio che avevano occupato sulla parete; assenti, temporaneamente “fuori sede” per un prestito o per motivi di restauro oppure malauguratamente soggetti a una sparizione probabilmente definitiva, in quanto oggetti di furto. In questo caso alle immagini perdute Sophie supplisce sostituendo il vuoto causato dalla loro assenza con i testi descrittivi dettati dai custodi e da altro personale del museo relativi a ciascuna opera d’arte prima presente in quello spazio e adesso improvvisamente “invisibile”.
Il linguaggio verbale può restituire quindi in parte ciò che è scomparso, come nel caso dei pezzi trafugati dai musei, e partecipare al tentativo di risarcire una mancanza originaria, servire a dare fisionomia e corpo a ciò che è stato negato appunto fin dall’origine, come nel caso di Les Aveugles. Ma, si badi bene a non equivocare, a non dare troppa importanza a questo aspetto poiché ancora una volta il vero tema è lo sguardo, il guardare e il suo legame con la conoscenza, nucleo nevralgico della cultura occidentale. L’artista racconta in questo modo la genesi di quest’opera:
Avevo incontrato un gruppo di ciechi per strada e uno di loro stava dicendo agli amici: “Ieri ho visto un film bellissimo”. Mi ci sono voluti due anni per finire il lavoro, temevo l’elemento di crudeltà implicito nel chiedere a un cieco cosa fosse la bellezza. Non è un’investigazione sull’idea di bellezza, non mi interessava poter dire che i ciechi possono vedere. Con Les Aveugles abbiamo di nuovo l’idea del guardare senza esser guardati.10
Sembra che parole e immagini assedino la realtà ordinaria stabilendo rituali e cercandovi un ordine e un senso che resta per lo più negato, tanto a chi vive quanto a chi è solo testimone, tanto ai vedenti quanto ai ciechi.
Forse è per questo che col passare del tempo nel suo lavoro prende sempre più importanza la componente fiction alla base del meccanismo creativo. L’apoteosi si da nel recente e interessantissimo “doppio gioco” messo in piedi con lo scrittore americano Paul Auster (New Jersey 1947). Antefatto: in Leviatano (1992) lo scrittore ha “vampirizzato” alcuni aspetti della personalità di Sophie per costruire il personaggio di Maria, che , come è ovvio, è frutto di una mescolanza tra spunti tratti dalla realtà ed elementi di pura finzione. La reazione di Sophie è sorprendente: sedotta da questo doppio di se stessa, ha deciso di giocare con il romanzo di Auster e di mescolare a sua volta le carte tra realtà e finzione.
Calle a quel punto non solo decide di obbedire al romanzo e “vivere alla lettera” il modello proposto dal suo alter ego, ma rilancia decisamente il gioco nella direzione della fiction. Non le basta aver tratto ispirazione a sua volta a quei lati di Maria che non erano già suoi (si è per esempio messa a seguire una dieta alimentare cromatica: il lunedì mangiava solo cibi arancioni, il martedì solo rossi, ecc…); va quindi direttamente in cerca dell’autore per chiedergli di delineare la storia che lei avrebbe vissuto nei suoi prossimi 365 giorni di vita; l’artista si sarebbe attenuta ai gesti inventati per lei dallo scrittore, che però non ha voluto assumersi la responsabilità delle conseguenze che gli atti da lui dettati avrebbero potuto comportare, sottraendosi in questo modo alla realizzazione del sogno di ogni artista incarnato da Pigmalione, rinunciando cioè a dare vita reale a un personaggio nato nella propria immaginazione. Ma Auster non si nega completamente: egli fornisce a Sophie una sorta di manuale intitolato Istruzioni personali per Sophie Calle alfine di migliorare la vita a New York (perché lei me l’ha domandato...). L’artista ha rispettato le direttive ivi contenute, una delle quali consisteva nel creare un luogo pubblico: Sophie ha decorato una cabina telefonica e l’ha usata per servire del cibo. I risultati di questa operazione sono stati da lei annotati con minuzia: 125 sorrisi dati, 72 ricevuti, 2 sandwiches accettati, 10 rifiutati. Il progetto è documentato nel volume che s’intitola Gotham Handbook. New York, istruzioni per l’uso (1994)11, contenuto in Double Game, che da conto integralmente dell’esperienza di dialogo con Auster.
Dopo questo breve excursus vediamo di ripercorrere in filigrana l’opera di Calle per scorgerne il ruolo che la figura dell’autore vi svolge. La mobilità del gioco dell’autore si organizza qui in una serie di sfumature comprese nell’arco dell’oscillazione fra poli opposti: quello della sparizione, dell’assenza e della cancellazione e quello dell’affermazione e della presenza attraverso il racconto autobiografico e la performance. Complesso è il rapporto che si instaura inoltre tra autore, narratore e personaggio; le tre figure spesso slittano fino a sovrapporsi oppure a volte si fagocitano a vicenda oppure pacificamente si scambiano i ruoli.
Abbiamo già visto la reversibilità del suo agire: è un autore a caccia di personaggi (come sin dal principio in Suite venitienne), mentre nella vicenda con Paul Auster si è comportata come un personaggio in cerca d’autore.
Sophie Calle sembrerebbe quindi abdicare alla rivendicazione di un’autorialità piena, intesa come attuazione di un progetto a priori di cui sono chiari tutti i passaggi dall’ideazione fino alla realizzazione attraverso un controllo attento e calibrato12, ricercando invece pervicacemente l’intervento di fattori e agenti esterni alla propria sfera personale, indipendenti dalla propria volontà e perfino dalla propria previsione.
La vera domanda potrebbe essere: in questo modo Sophie Calle rinuncia alla pienezza autoriale come sembra o in realtà, “cannibalizzando” il resto, l’altro da sé, non fa che dilatare, espandere e rafforzare la figura dell’autore?
La risposta non è immediata e meriterebbe una serie di riflessioni che per il momento vengono sospese: è sufficiente per adesso poter dire che l’opera di Sophie Calle si regge sempre più, oltre che su un forte istinto letterario, anche sulla progressiva e sempre più sostanziale assunzione dei meccanismi creativi propri della letteratura.
Il suo successo internazionale come artista è spiegabile nel panorama del mondo attuale con il prepotente ritorno di un bisogno di storie dopo gli anni di “dieta strutturalista e concettuale”; perché sul finale di ogni storia che, per particolare e “minima” che sia, Sophie propone alla nostra immaginazione è come se fosse scritto de te fabula narratur .
Pour citer cet article :
Elisabetta Longari, " Qual è il gioco di Sophie Calle? Appunti sulla figura dell’autore nell’opera di Sophie Calle", Publif@rum, 2, 2005
© Les références et documents disponibles sur ce site, sont libres de droit, à la condition d'en citer la source