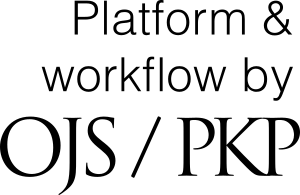AG - About Gender
Rivista riconosciuta da ANVUR ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per le Aree 11, 12 e 14, con collocazione in fascia "A" per l'area scientifico-disciplinare 14C1 (Sociologia generale) e 14 C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).
La nostra rivista è indicizzata su DOAJ (Directory of Open Access Journals).
ISSN 2279-5057